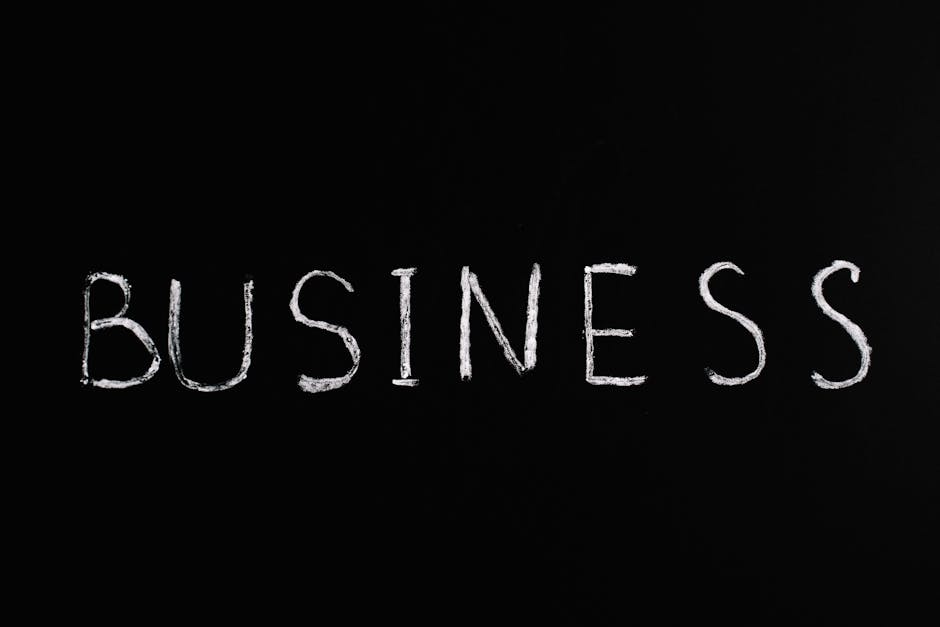Contesto della vicenda e le ragioni delcontestazione del docente
Una docente specializzata in Scienze Agrarie, impiegata presso un istituto superiore di Castelfranco Veneto, aveva presentato un ricorso contro il Ministero dell’Istruzione e l’istituto scolastico. Il motivo? Nell’anno scolastico 2019/2020 le veniva assegnata esclusivamente a classi del biennio (prime e seconde), mentre negli anni precedenti aveva insegnato anche nel triennio superiore.
La docente sosteneva che questa assegnazione violasse il principio di continuità didattica, principio volto a tutelare il percorso formativo degli studenti. Inoltre, lamentava di essere penalizzata rispetto a colleghi con minore anzianità di servizio, chiedendo quindi un risarcimento per danni percepiti come ingiusti.
Richieste della docente e evoluzione del procedimento giudiziario
Tra le richieste avanzate, vi erano:
- un congruo risarcimento per il danno da demansionamento, stimato in circa 40% dello stipendio lordo per due anni;
- il rimborso per la mancata partecipazione come commissario agli esami di maturità, pari a circa 1.140 euro;
- un riconoscimento per danno all’immagine professionale.
Il Tribunale del Lavoro di Treviso respinse il primo ricorso nel gennaio 2022. Anche in secondo grado, la richiesta di risarcimento venne respinta, consolidando la posizione della Corte.
Il ruolo della Corte d’Appello e la sua decisione sulla continuità didattica
La Corte d’Appello di Venezia ha stabilito che l’assegnazione delle classi scolastiche non può essere contestata invocando il principio di continuità didattica. I giudici hanno chiarito che tale principio serve a garantire agli studenti un percorso formativo coerente e omogeneo nel tempo.
Le motivazioni della decisione
- Il concetto di continuità didattica si riferisce esclusivamente alla tutela degli alunni, non ai movimenti o alle assegnazioni dei docenti.
- Nel caso specifico, la docente aveva comunque svolto parte del suo insegnamento nelle classi dell’anno precedente, nelle quali aveva tenuto alcune materie e ne aveva iniziato altre.
- Per le classi del triennio non assegnate, i giudici hanno evidenziato che le variazioni di programma e di discipline insegnate escludevano una vera e propria continuità educativa.
Gli aspetti relativi al risarcimento e alle prove di danno
Le richieste di risarcimento sono state tutte rigettate, in quanto non sono state provate le effettiveesistenza di danni concreti. In particolare, la Corte ha osservato che:
- Il demansionamento non sussiste, poiché non esiste una gerarchia di qualifiche tra le materie insegnate nella stessa classe di concorso.
- La partecipazione come commissario di esami era comunque prevista, e le circostanze eccezionali legate alla pandemia hanno rallentato le nomine.
- Il danno all’immagine professionale è stato ritenuto troppo vago e privo di prove concrete.
Infine, la docente è stata condannata a dover sostenere le spese processuali.
Conclusioni: La sentenza ribadisce che il principio di continuità didattica tutela esclusivamente gli studenti e non può essere usato come motivo di contestazione da parte dei docenti sulle assegnazioni di classi. Per ottenere un risarcimento, è invece necessario dimostrare danni effettivi, cosa che nel caso in esame non è avvenuta.
La continuità didattica è un principio che garantisce un percorso formativo coerente nel tempo agli studenti. La docente contestava l'assegnazione delle classi, sostenendo che questa violasse tale principio, in quanto limitava le sue possibilità di insegnare in diversi anni scolastici e avrebbe compromesso la continuità educativa per gli studenti.
Le corti hanno ritenuto che le prove presentate dalla docente non dimostravano danni concreti o violazioni effettive del principio di continuità didattica. Di conseguenza, tutte le richieste di risarcimento sono state respinte per mancanza di evidenze sufficienti.
La Corte d’Appello ha esaminato il ricorso del docente ed ha deciso che il principio di continuità didattica tutela esclusivamente gli studenti, non i docenti. Pertanto, ha respinto l’istanza di contestazione dell’assegnazione delle classi da parte del professore.
I giudici hanno chiarito che la continuità didattica si riferisce esclusivamente alla tutela degli alunni, assicurando un percorso coerente e omogeneo nel tempo, e non riguarda le decisioni o i movimenti dei docenti.
Secondo la Corte, le variazioni nelle assegnazioni e nei programmi di insegnamento, specialmente tra classi diverse o trienni, escludono che si possa parlare di una vera e propria continuità educativa, poiché il percorso formativo diventa meno coerente e omogeneo.
Le motivazioni principali sono la mancanza di prove concrete di danni effettivi, come demansionamento o danno all’immagine professionale, e la constatazione che le variazioni nelle assegnazioni non comportano violazioni del principio di continuità didattica.
Sì, la sentenza chiarisce che i docenti non possono basare contestazioni sulle assegnazioni delle classi invocando la continuità didattica, poiché questa tutela solo gli studenti e non si applica alle scelte del personale docente.
Per ottenere un risarcimento, sarebbe necessario dimostrare in modo concreto e documentato che l'assegnazione delle classi abbia causato danni effettivi, come perdita di incarichi o danno alla reputazione professionale, con prove certe e riconosciute.
Questa sentenza si distingue perché ribadisce che la continuità didattica protegge esclusivamente gli studenti, non i docenti, evidenziando come le assegnazioni delle classi siano decisioni che non devono essere contestate sulla base di questo principio.
I giudici intendono sottolineare che il principio di continuità didattica serve esclusivamente a tutelare gli studenti, e che i docenti non possono usarlo come base per contestazioni sulla loro assegnazione. Per richiedere risarcimenti, devono dimostrare danni concreti e specifici, non semplicemente indirizzare contestazioni sulla base di questo principio.